Come fu che ci incontrammo?
A un esame. Ero lì che vagavo in cerca di un posto in cui sedere e una ragazza mora, con un paio di occhiali da miope peggio dei miei mi fece segno di accomodarmi accanto a lei. Un gesto inaspettato che si trasformò in fretta in uno scambio di suggerimenti reciproci e bigliettini. Superammo quell’esame, proprio quella volta e insieme, dopo mille tentativi di entrambe. Stavamo cercando di laurearci, tardi perché avevamo avuto una serie di intoppi, ognuna per i propri motivi. Quindi l’iter comune fu: ritiro dal precedente corso quadriennale > riconoscimento di carriera > iscrizione alla laurea triennale. Una frustrazione che sarebbe stata umiliante se non fosse stato che attorno ai trent’anni – poco meno lei, poco di più io – ci interessava ben poco la qualità della laurea. Ci serviva il pezzo di carta e avremmo accettato anche una sfilza di diciotto.
Quando andammo in dipartimento a far firmare il voto, Emilia, questo era il suo nome, sbottò. Il lunedì successivo avrebbe compiuto trent’anni anni; lo avrebbe detto alla docente se il voto fosse stato troppo basso. Un diciotto le sarebbe andato più che bene.
«Quando, scusa?» Chiesi io. «Il compleanno, intendo.»
«Lunedì, il 15, perché?» Mi guardò incuriosita.
«Anche io! Il 15 marzo ne faccio trentatré!»
Ottimo! Facciamo una festa insieme, che bello, vedi che non ci si incontra mai per caso, guarda le coincidenze, ma non sono coincidenze, era scritto nel libro del fato, era destino che quel giorno la sedia fosse libera, ci siamo riconosciute al primo sguardo, eccetera.
E via a farci viaggi mentali, una più stordita dell’altra.
Nasceva un’amicizia delle più importanti che ebbi durante il periodo universitario, forse una delle più importanti della mia vita.
Emilia viveva in un minuscolo paesino, una frazione di Villafranca. La prima volta che andai a trovarla, scesi dal treno a Verona e mi fulminò un pensiero.
Avrei voluto avere dei pattini.
Ho sempre amato i pattini. Da piccola io e la mia amichetta di allora – generazione di bambini che ancora giocavano nei cortili e per le strade – andavamo in giro ovunque nel quartiere con i pattini addosso: marciapiedi, cantine e solai, non ce li toglievamo mai.
I miei avevano una specie di scarpa da ginnastica; i suoi erano più belli: agonistici con lo stivaletto bianco e ruote fluidissime. Glieli aveva spediti sua mamma che faceva la modella negli USA. L’amica schizzava veloce come una saetta e io rimanevo sempre indietro, ma questo non ha mai incrinato il divertimento di quei pomeriggi in cui sua nonna minacciava e pronosticava sventure: «Fa ancora troppo caldo! Suderete troppo! Prenderete un’insolazione!».
La nostra pista preferita era un lungo garage sotterraneo in un condominio vicino a casa, con il pavimento in piastrelle perfettamente lisce. Lì si volava, alla lettera.
Be’ ecco, arrivata alla stazione di Verona, con tutto quel marmo levigato, quello mi venne in mente: avrei voluto i miei pattini. E soldi. Il sottopassaggio era una galleria di negozi uno più interessante dell’altro. Si respirava subito l’odore della città turistica. La voglia di comprare qualche souvenir ti pigliava d’assalto già nell’atrio principale.
Non rimpiansi più i pattini la volta in cui mi venne a prendere in scooter. Il suo modo disinvolto di guidare un po’ mi inquietava e tanto mi divertiva. Sfrecciammo davanti a Porta Nuova e nemmeno si prese la briga di spenderci due parole.
«Questo è il quartiere di Santa Lucia» disse poi, ma mentre cercavo di osservare quel che avevo attorno, gli edifici volavano all’indietro mentre lei strombazzava col ridicolo clacson dello scooter a ogni incrocio o a ogni cancello. «Me l’ha insegnato Luca», diceva.
Luca era il suo compagno, andava in moto e farsi notare il più possibile era la sua regola principale: fari accesi sempre e clacson a ogni piè sospinto. Vivevano in questa casa di campagna a tre piani nel mezzo di una corte in cui i vicini si scambiavano favori vicendevoli: la bottiglia di latte appena munto, la polenta appena cotta o il salame fatto in casa. Fu lì che conobbi le fritole (frittelle dolci buonissime) per la prima volta. Realtà lontane dalla diffidenza cittadina.
La casa di Emilia aveva un ché di esoterico, era incenso e tè, legno e coperte calde. Come a casa mia si camminava solo scalzi o con ciabatte pulite. Abitudini sacre apprese in Oriente dove, per motivi diversi, eravamo state entrambe.
Aveva due gatti e due cani e ricordo distintamente che io non volevo i gatti nella mia stanza di notte. Come si cambia!
Da Emilia stavo benissimo, era una delle persone più divertenti che avessi mai conosciuto, con lei facevo certe risate che mi scatenavano una tosse terribile. Era più che divertente, era comica. Un senso dell’umorismo e dell’autoironia davvero rari e preziosi.
Iniziammo a preparare molti esami insieme. Da Padova salivo sul treno per Verona e lei mi veniva a prendere, una volta in auto, una volta in scooter. Stavamo da lei giorni, se non settimane, a studiare come forsennate. Avevamo anche stabilito l’abitudine di scegliere una tazza per il tè, che fosse e rimanesse quella per tutto il periodo della preparazione all’esame di turno. Alla fine, ovviamente, ci voleva la candeggina per smacchiarla, ma era una specie di certezza, un rito oltre che una coccola.
Scoprimmo di avere entrambe la passione delle freccette e mi portò in un locale vicino a Quaderni, piuttosto esotico, in cui si poteva bere birra e giocare, proprio come nei film americani. Il problema era che dopo un certo numero di pinte non solo mancavamo il centro, ma proprio il bersaglio.
I maschi che erano usciti con noi, il suo compagno e un altro ragazzo che proprio non ricordo, all’inizio erano orgogliosi di portarsi appresso due femmine di tal sorta, ma la situazione cambiò drasticamente quando il nostro lato ribelle venne fuori con quelle birre in più e quei lanci pericolosi. Emilia e io eravamo simili come una rosa e un girasole: niente in comune, almeno esteticamente, ma avevamo avuto infanzia e adolescenza inenarrabili e questo, forse, ci spingeva a schiacciare l’acceleratore della vita in modo talvolta sguaiato.
La più spassosa di tutte, fu la fiera del Patrono di Villafranca, che si tiene ogni anno per una settimana in occasione del giorno dei Santi Pietro e Paolo.
Una fiera che deve le sue origini all’epoca del dominio della Serenissima; le prime notizie certe risalgono al 1714, anno in cui al tradizionale mercato del mercoledì mattina venne aggiunta anche la sagra in occasione del 29 giugno, festa dei patroni. Una concessione per superare il grave periodo di crisi. Nel corso degli anni la fiera si è evoluta, ha perso la caratteristica iniziale di compravendita del bestiame ed è diventata una rassegna di prodotti commerciali e artigianali. Il tutto condito con spettacoli, manifestazioni culturali e sportive, luna-park e fuochi artificiali. Attrae persone di tutta la provincia e anche oltre, una vera fiumana di gente si avventura fin lì dal mantovano e dal bresciano.
Lo spettacolo pirotecnico si tiene al castello ed è sensazionale, tra i più belli che abbia mai visto. Ma il vero divertimento fu andare sugli autoscontri con Emilia che, inconsapevole della mia pericolosità, urlò e rise per tutto il tempo in cui andammo allo sbaraglio sulla macchinina. Credo che non ci sia niente che mi divertisse più degli autoscontri. In assoluto. Adoravo premere l’acceleratore a fondo e puntare dritto verso un’altra auto. Emilia continuava a ridere e a gridare che ero pazza. Ecco, ho sbagliato, c’è una cosa che mi divertiva più degli autoscontri: andare sugli autoscontri con Emilia.
Una sera il cane del vicino si era messo ad abbaiare come un dannato e non la finiva più. Le prestai un paio di tappi per le orecchie, comprati in ferramenta, non in farmacia. La differenza è che quelli per lavoratori sono più soffici e tengono meglio la forma. La mattina dopo lo raccontò con un messaggio a un’amica, la quale rispose “Sei proprio sicura che questi tassi debbano andare nelle orecchie?”
Nulla da fare, Emilia non ricontrollava mai i testi prima di inviare ed era costante vittima del T9. I suoi SMS erano più o meno sempre involontariamente esilaranti.
Tutto quello che facevo con Emilia mi divertiva, a dire il vero. Oscillavamo tra lo spirituale e il faceto, tra tarocchi ed esami di linguistica inglese. Tra passeggiate coi cani nei i campi di pesche di Quaderni, che, mi diceva, sono fra le più pregiate della zona, e lanci di freccette che rischiavano di accecare i nostri accompagnatori.
Era meglio, molto meglio, che andare in pattini. Era come quella volta in cui andai a sentire Keith Jarrett all’Arena, nel 1995: esaltante, tangibile e mistico allo stesso tempo. Impareggiabile come il luogo in cui aveva deciso di elargire la sua arte. In occasione del concerto, però, non ero passata per la stazione e non mi era venuta voglia di pattinare. Era bastato lui, imponente eppure minuto fin quasi a perdersi dentro quell’immenso e ineguagliabile edificio. Perfetti, maestosi. Precisi come un metronomo e inderogabili come l’incontro con Emilia.
Qualche tempo dopo l’università finì, mi trasferii in Cina, lei si sposò. Banale, sciocco, eppure… A dirlo non ci si crederebbe: è da allora che non ci rivediamo. Solo foto e like su Facebook.
Dovrei tornare da Emilia. La sua vita è cambiata tanto, come la mia del resto. Non vive più in una frazione di Villafranca, è tornata in città e chissà se l’appartamento nuovo è esoterico come quello che conoscevo.
Questo mi spiace, Emilia mi manca. Mi mancano le risate, ma mi manca soprattutto quello che ci conduceva a quelle risate.
Inutile aggiungere che il 15 marzo di ogni anno il mio pensiero va a lei, ogni volta spero di essere la prima a farle gli auguri. Se esiste un’anima che sento affine, per mille motivi di cui solo ultime sono le risate, questa è lei. Abbiamo entrambe la nostra migliore amica e non è una sostituzione. Non c’entra nulla, è un rapporto diverso. È una corsa in scooter tra i marmi di Verona, è un voto basso di cui non ci è mai fregato nulla, è una catasta di libri a cui poi abbiamo dato fuoco per liberarci di pesi che gravavano più sull’anima che sulla schiena, è la magnificenza del castello di Villafranca addobbato a festa. È la storia di due grandi solitudini che si sono incontrate in una risata spudorata e genuina. Alla faccia di tutto il male che la vita non ci ha mai risparmiato.




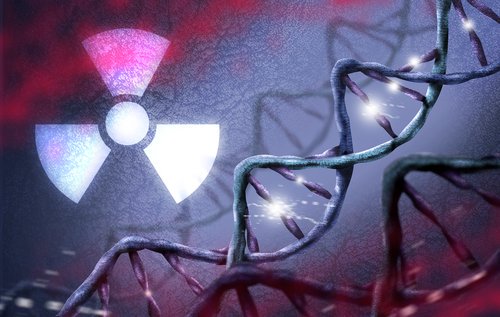



 Esiste una piattaforma che si chiama Wattpad (sì, lo so che lo sapete, ma vorrei farci una riflessione sopra).
Esiste una piattaforma che si chiama Wattpad (sì, lo so che lo sapete, ma vorrei farci una riflessione sopra).